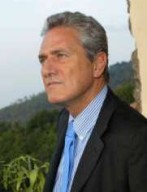“L’Italia è un Paese perdonista, ma meno disposto ad aiutare i bisognosi”
"Restituire dignità alla misericordia - spiega monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio -, ridandole il posto di cuore pulsante. È questa la sfida vinta dal Giubileo. Quella da vincere, invece, è farla diventare cultura, come raccomanda Francesco nella “Misericordia et misera”, la lettera apostolica a chiusura dell’Anno santo straordinario della misericordia"

«L’Italia è un Paese “perdonista”, in cui però è in netta diminuzione la tendenza a voler aiutare i bisognosi». È quanto emerge dalla ricerca su “Gli italiani e la misericordia”, una sorta di “bilancio laico” del Giubileo appena trascorso, curato dal Censis e presentato ieri a Roma. La misericordia celebrata ha attecchito meno della misericordia vissuta, il dato saliente del rapporto, in cui si scopre che gli italiani sono molto propensi a perdonare familiari e amici e molto meno, per esempio rispetto ai tempi di guerra, ad aiutare chi ha bisogno.
Nel 2013, stando ai dati del Censis, le persone che dichiaravano che l’idea di aiutare chi è in difficoltà avrebbe dato una grande carica erano il 29,5%: percentuale che nel 2016 è scesa all’11,7%. Oggi il 17,5% vede con entusiasmo l’idea di dare una mano ai bisognosi. Si tratta pur sempre, sottolinea il Censis, di un quinto degli italiani.
Al di là dei dati, comunque, il Giubileo della misericordia appena conclusosi ci lascia in eredità due sfide: «Restituire dignità alla misericordia – spiega monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio -, ridandole il posto di cuore pulsante. È questa la sfida vinta dal Giubileo. Quella da vincere, invece, è farla diventare cultura, come raccomanda Francesco nella “Misericordia et misera”, la lettera apostolica a chiusura dell’Anno santo straordinario della misericordia».
Durante questo anno giubilare, per Fisichella, la misericordia è entrata nel linguaggio non solo della Chiesa, ma in quello comune: «Di qui la necessità – aggiunge – di tradurla in comportamenti, a partire dal mettere in pratica le opere di misericordia corporale e spirituale. Sono opere artigianali che, quando diventano patrimonio della vita della Chiesa, possono dar luogo a una rivoluzione culturale che incide sulla vita della società e delle persone».
E la verifica sugli esiti del Giubileo, anche dal punto di vista prettamente laico, ha riguardato anche la città che più di ogni altra l’ha ospitato, ovvero Roma: «La città non c’è stata – osserva Giuseppe De Rita, presidente del Censis -. È rimasta prigioniera di un turismo di serie B, di un bed and breakfast continuato».
Secondo il sociologico, durante l’anno giubilare appena trascorso – a differenza di quanto era avvenuto nel Giubileo del 1950 e in quello del Duemila –, non c’è stato un rapporto col Giubileo di tipo partecipativo: «Roma – sottolinea De Rita – era una città straniata. È un problema aperto, che dovremmo porci per il futuro. Non è colpa del Giubileo, è colpa della città che non si è neanche interrogata su questo. La questione riguarda l’amministrazione civile, ma anche la Chiesa romana che ha perso quella soggettività che aveva faticosamente conquistato negli ultimi decenni».
Su questa stessa linea anche l’ex sindaco capitolino e attuale presidente di “Priorità cultura” Francesco Rutelli: «Roma – evidenzia colui che guidò la cabina di regia del Giubileo del Duemila – non si è ricordata della propria universalità, che non è solo quella della cattolicità. Roma è universale dal punto di vista laico e civile non meno che da quello religioso. Durante l’anno giubilare appena trascorso, non c’è stata una grande mostra, un grande evento, un fatto organizzato dall’amministrazione civile per segnalare la connessione tra i valori di cui si è fatto promotore il Papa e i significati di portata universale di cui è intrinsecamente portatrice di questa città».
Per quanto riguarda la sicurezza, invece, il Giubileo di Papa Francesco, iniziato a Roma sotto il sinistro segnale degli attentati di Parigi, nulla da eccepire: «Grazie – conclude – al lavoro meritorio di prevenzione, di intelligence, di presenza a tappeto delle forze dell’Ordine, si è svolto in pace e sicurezza, frutto della dedizione silenziosa delle autorità pubbliche preposte. A differenza, per esempio di Parigi, che dopo gli attentati terroristici è piombata nella depressione e ha vissuto una vera e propria crisi di identità, tanto che il museo del Louvre ha perso quest’anno un terzo dei suoi visitatori».