Homo capax Dei
Cosa sono dunque, Dio mio? Qual è la mia natura? Una vita varia, multiforme, di un'immensità poderosa (S. Agostino, Confessioni X, 17,26)

«A questo tende tutta la teologia di San Tommaso d’Aquino: a condurci a vivere una vita intima con Dio». Con questa citazione di Pio XI si apre un libro, recentemente pubblicato dalla Casa Editrice Leonardo da Vinci, sul tema della contemplazione e della conoscenza mistica nella Summa contra Gentiles di Tommaso d’Aquino. L’autore, Alessandro Beghini, è docente di discipline giuridiche ed economiche e ha compiuto i suoi studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Lateranense per poi specializzarsi in teologia spirituale presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Il testo si compone di quattro capitoli in cui l’autore espone la dottrina sulla contemplazione di Tommaso d’Aquino, analizzando uno dei testi più importanti dell’Aquinate, la Summa contra Gentiles, soffermandosi in particolare sul III libro di questo capolavoro filosofico-teologico. Il fine è mostrare come nell’opera tommasiana sia possibile «rinvenire una ricchezza spirituale che, seppur esposta con il linguaggio impersonale della dottrina, ci lascia intendere e scoprire la ricchezza del vissuto cristiano» (p. 12). Il primo capitolo (pp. 17-34), intitolato “La Summa contra Gentiles nel panorama dell’opera di Tommaso d’Aquino”, è — come si può facilmente intuire — una presentazione dell’opera dell’Aquinate, nonché un’esposizione dei contenuti teologico-spirituali presenti nel testo. Beghini, infatti, non solo descrive il contesto di produzione, ma enuclea i temi fondamentali dell’opera: la creazione, l’ordinamento della creazione, il completamento della creazione in Dio. Di estrema importanza è il riferimento, nella parte conclusiva, al primo capitolo del quarto libro della Somma contro i Gentili, nel quale Tommaso spiega che tre sono i modi per conoscere Dio: la conoscenza mediante la luce naturale della ragione, la conoscenza mediante la testimonianza (Rivelazione) e, infine, la conoscenza perfetta delle cose rivelate (visione beatifica). Il secondo capitolo (pp. 35-66), “Homo capax Dei: cenni di antropologia tommasiana e vita mistica”, è una riflessione sull’antropologia di Tommaso d’Aquino. Il capitolo è di estremo interesse, in quanto evidenzia un fatto immediatamente evidente: l’uomo è un essere qualitativamente superiore rispetto a tutti gli altri esseri e che, proprio per questa ragione, ha la possibilità di cercar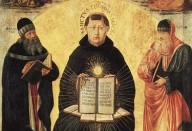 e Dio (è, appunto, capax Dei), unico essere in grado di appagare — secondo la nota espressione agostiniana — l’inquietudine del cuore (cfr. Agostino, Confessioni I, 1.1): «Nella Somma contro i Genitli — leggiamo nella parte centrale del capitolo — il Dottore Angelico scrive che in un certo senso tutte le creature sono a immagine di Dio, ma le creature intellettuali hanno in più la somiglianza. “L’uomo è stato creato a immagine di Dio perché partecipa alla sua luce intellettuale” (SCG III, 1)» e questo, attraverso un percorso sostenuto dalla Grazia divina, «permette, come afferma l’Aquinate nel libro IV (c. 91, 1), all’anima di “diventare capace della visione di Dio alla quale non poteva giungere mentre era unita al corpo corruttibile. E proprio nella visione di Dio consiste l’ultima beatitudine dell’uomo”» (pp. 59, 66). Il capitolo terzo (pp. 67-110), “La contemplazione nel libro III della Summa contra Gentiles”, è la parte più importante del saggio: l’autore analizza attentamente i capitoli del terzo libro della Summa, mostrando che l’uomo può trovare la felicità ultima solo in Dio: «La felicità dell’uomo, ci dice Tommaso, consiste nel soddisfacimento del desiderio naturale di vedere Dio: solo quando questo accadrà l’intelletto otterrà l’ultima felicità poiché il desiderio di conoscere la verità si acquieta solo in Dio e si può arrivare a quella conoscenza solo se Dio si dà alla visione dell’uomo e permette all’uomo di partecipare della sua beatitudine» (p. 71). Tuttavia questo traguardo può essere raggiunto solo se l’uomo non si chiude alla Grazia di Dio che sostiene il cammino dell’homo viator: «Quindi, potremmo dire, che Tommaso sembra ribadire con questo argomento [si sta parlando della predestinazione, della riprovazione e dell’elezione divina], ancora una volta, quella che è la vocazione naturale dell’uomo alla visio Dei per mezzo della Grazia» (p. 108). Il quarto capitolo (pp. 111-132), “Tommaso d’Aquino maestro di contemplazione per l’uomo d’oggi”, è dedicato alla presentazione di Tommaso come maestro di vita spirituale. In questo senso, il lavoro di Beghini non è una semplice ripresa del passato, un ritorno nostalgico al vecchio, ma un’attenta riflessione che ha per oggetto un pensiero ancora attuale, e quindi «il percorso spirituale che l’Aquinate ci ha lasciato intravedere nella sua opera non può essere lontano dall’uomo che anche oggi cerca bellezza, contemplazione, felicità, verità, amore» (p. 144; per approfondire l’itinerario di Tommaso clicca qui).
e Dio (è, appunto, capax Dei), unico essere in grado di appagare — secondo la nota espressione agostiniana — l’inquietudine del cuore (cfr. Agostino, Confessioni I, 1.1): «Nella Somma contro i Genitli — leggiamo nella parte centrale del capitolo — il Dottore Angelico scrive che in un certo senso tutte le creature sono a immagine di Dio, ma le creature intellettuali hanno in più la somiglianza. “L’uomo è stato creato a immagine di Dio perché partecipa alla sua luce intellettuale” (SCG III, 1)» e questo, attraverso un percorso sostenuto dalla Grazia divina, «permette, come afferma l’Aquinate nel libro IV (c. 91, 1), all’anima di “diventare capace della visione di Dio alla quale non poteva giungere mentre era unita al corpo corruttibile. E proprio nella visione di Dio consiste l’ultima beatitudine dell’uomo”» (pp. 59, 66). Il capitolo terzo (pp. 67-110), “La contemplazione nel libro III della Summa contra Gentiles”, è la parte più importante del saggio: l’autore analizza attentamente i capitoli del terzo libro della Summa, mostrando che l’uomo può trovare la felicità ultima solo in Dio: «La felicità dell’uomo, ci dice Tommaso, consiste nel soddisfacimento del desiderio naturale di vedere Dio: solo quando questo accadrà l’intelletto otterrà l’ultima felicità poiché il desiderio di conoscere la verità si acquieta solo in Dio e si può arrivare a quella conoscenza solo se Dio si dà alla visione dell’uomo e permette all’uomo di partecipare della sua beatitudine» (p. 71). Tuttavia questo traguardo può essere raggiunto solo se l’uomo non si chiude alla Grazia di Dio che sostiene il cammino dell’homo viator: «Quindi, potremmo dire, che Tommaso sembra ribadire con questo argomento [si sta parlando della predestinazione, della riprovazione e dell’elezione divina], ancora una volta, quella che è la vocazione naturale dell’uomo alla visio Dei per mezzo della Grazia» (p. 108). Il quarto capitolo (pp. 111-132), “Tommaso d’Aquino maestro di contemplazione per l’uomo d’oggi”, è dedicato alla presentazione di Tommaso come maestro di vita spirituale. In questo senso, il lavoro di Beghini non è una semplice ripresa del passato, un ritorno nostalgico al vecchio, ma un’attenta riflessione che ha per oggetto un pensiero ancora attuale, e quindi «il percorso spirituale che l’Aquinate ci ha lasciato intravedere nella sua opera non può essere lontano dall’uomo che anche oggi cerca bellezza, contemplazione, felicità, verità, amore» (p. 144; per approfondire l’itinerario di Tommaso clicca qui).




