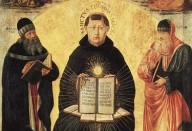Fede e ricerca teologica
La teologia sia al servizio della fede dei cristiani, si metta umilmente a custodire e ad approfondire il credere di tutti, soprattutto dei più semplici. Inoltre, la teologia, poiché vive della fede, non consideri il Magistero del Papa e dei Vescovi in comunione con lui come qualcosa di estrinseco, un limite alla sua libertà, ma, al contrario, come uno dei suoi momenti interni, costitutivi, in quanto il Magistero assicura il contatto con la fonte originaria, e offre dunque la certezza di attingere alla Parola di Cristo nella sua integrità (Francesco, Lumen Fidei, 36).
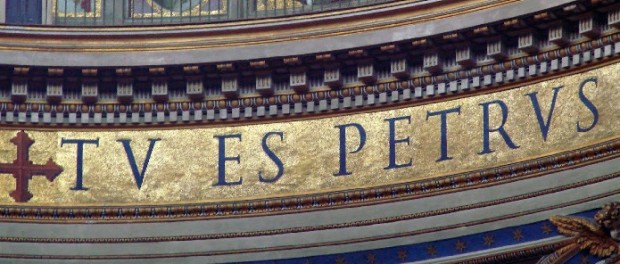
La Chiesa «con l’ufficio di insegnare, ha ricevuto il mandato di custodire il deposito della fede, [e] ha, anche, da Dio, il diritto e il dovere di proscrivere la falsa scienza [1 Tm 6,20], perché nessuno venga ingannato dalla filosofia e da vuoti raggiri [Col 2,8]» (Concilio Vaticano I: Cost. dogm. «Dei Filius», in H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, n. 3018). Questo diritto e dovere della Madre Chiesa salvaguarda da una creatività (a dir poco bizzarra) di voler insegnare ciò che non è conforme al depositum fidei, quindi ciò che non è conforme all’insegnamento che Cristo ha affidato agli Apostoli quando ci ha fatto la grazia di vivere in mezzo a noi.
Alla luce di quanto detto risulta pienamente comprensibile il motivo per cui il Magistero rifiuti metodologie di ricerca come quelle per esempio del razionalismo moderno o che condanni falsi concetti di libertà che servono solo a coprire la propria malizia; inoltre si comprende facilmente che in questo senso gli stessi solenni pronunciamenti sono un materno richiamo per evitare di lasciarsi condizionare dalle mode culturali del momento che, per quanto siano apprezzate e celebrate, risultano infondate ad un attenta analisi razionale. L’intervento, quindi, ha l’obiettivo di custodire il deposito della fede, come già detto, la sua retta interpretazione e richiamare il teologo (e tutti i fedeli), nonostante le buone intenzioni di servire la verità rivelata, alla prudenza di fronte ad una metodologia di ricerca, che solo in apparenza risulta compatibile con la teologia cattolica.
Proprio per questo la Chiesa propone alcune figure come guida, e su tutti Tommaso d’Aquino, esempio per la ricerca sia in campo filosofico che in quello teologico: la sapienza dell’Aquinate sta nell’aver ben compreso sia il valore della filosofia sia lo statuto proprio della teologia; infatti quando il Dottore Angelico si chiede con quale metodo proceda la teologia dichiara: «sicut aliae scientiae non argumentantur ad sua principia probanda, sed ex principiis argumentantur ad ostendendum alia in ipsis scientiis; ita haec doctrina non argumentatur ad sua principia probanda, quae sunt articuli fidei; sed ex eis procedit ad aliquid aliud ostendendum (= come le scienze profane non devono dimostrare i propri principi, ma dai loro principi argomentano per dimostrare altre tesi, così la sacra dottrina non dimostrerà i propri principi, che sono gli articoli di fede, ma da essi procede per la dimostrazione di qualche altra cosa», Summa Theologiae I, q.1, a. 8). Come si evince dal testo appena citato, Tommaso mette ben evidenza il punto da cui deve partire il teologo e presenta anche un’interessante analogia tra il procedere della scienza filosofica e quello della scienza teologica: come le tesi filosofiche scadono in vuota retorica, quando si distaccano «dai loro principi», dalle prime certezze empiriche, assolutamente indubitabili e conosciuti da tutti, così le tesi dei teologi non possono definirsi tali se risultano non conformi alle “prime verità” costituite dal dogma, ossia dalla Parola di Dio così come essa viene proposta infallibilmente dalla Chiesa e che ogni cristiano è tenuto a credere come l’unica verità che salva (chiarissimo è questo passaggio di Tommaso: «Sed omnibus articulis fidei inhaeret fides propter unum medium, scilicet propter veritatem primam propositam nobis in Scripturis secundum doctrinam Ecclesiae intellectis sane. Et ideo qui ab hoc medio decidit totaliter fide caret [=La fede invece aderisce a tutti gli articoli del simbolo per un unico “medium”, cioè in forza della prima verità, presentata a noi dalla Sacra Scrittura bene interpretata secondo l’insegnamento della Chiesa. Perciò chi abbandona codesto “medium”, è privo totalmente di fede»]. Summa Theologiae, II-II, q.5, a. 3, ad.2).

Paolo Veronese, Disputa di Gesù fra i dottori del Tempio. 1562 ca. Madrid, Museo Nacional del Prado.
Benedetto XVI è tornato più volte su questo punto, ricordando che il teologo non deve venire meno alla sua vocazione e per far ciò non può dimenticare, quasi fosse un optional, che «il punto di partenza di ogni teologia cristiana è l’accoglienza della Rivelazione divina: l’accoglienza personale del Verbo fatto carne, l’ascolto della Parola di Dio nella Scrittura. Su tale base di partenza, la teologia aiuta l’intelligenza credente della fede e la sua trasmissione. Ogni lettura della Bibbia si colloca necessariamente in un dato contesto di lettura, e l’unico contesto nel quale il credente può essere in piena comunione con Cristo è la Chiesa e la sua Tradizione viva» (Udienza ai membri della Commissione Teologica Internazionale, 2 dicembre 2011). Come dimostra questo intervento e gli altri, sulla stessa linea, dei diversi Pontefici (vedi anche Francesco, Lumen Fidei, nn. 23-38), la questione è di notevole importanza. Tali chiarificazioni, infatti, hanno l’obiettivo di evitare – come dicevo poc’anzi – la spiacevole situazione che vede al Magistero affiancarsi una o più “voci” teologiche che invocano una libertà che per il teologo non può esistere dissociata dal “voce” del Magistero stesso. Le ipotesi di interpretazione del dogma devono andare nella medesima “direzione magisteriale”, pena è il venir meno della vocazione a cui è chiamato il teologo e la fine della scienza teologica stessa. Quanto detto è espresso con chiarezza maggiore dall’Istruzione Donum Veritatis, dove, al n.12, leggiamo: «La libertà di ricerca, che giustamente sta a cuore alla comunità degli uomini di scienza come uno dei suoi beni più preziosi, significa disponibilità ad accogliere la verità così come essa si presenta al termine di una ricerca, nella quale non sia intervenuto alcun elemento estraneo alle esigenze di un metodo che corrisponda all’oggetto studiato. In teologia questa libertà di ricerca si iscrive all’interno di un sapere razionale il cui oggetto è dato dalla Rivelazione, trasmessa ed interpretata nella Chiesa sotto l’autorità del Magistero, ed accolta dalla fede. Trascurare questi dati, che hanno un valore di principio, equivarrebbe a smettere di fare teologia». In questo senso lo spirito di ricerca non deve trasformarsi in criticismo che, come nel campo filosofico, recherebbe danni alla scienza stessa: se gli interventi del Magistero hanno giudicato e giudicano come inconciliabili con la fede alcune dottrine filosofiche, ogni cristiano, e ancor di più il teologo che, quando riceve il mandato di insegnare, partecipa, in un certo senso, all’opera del Magistero stesso (cfr. Donum Veritatis, n.22), deve rifiutarle per salvaguardare l’integrità della fede, custodita dalla Chiesa su comando di Cristo.
Voglio, per concludere, richiamare un martire del II secolo, s. Ignazio d’Antiochia che, rivolgendosi ai cristiani di Tralle, nella sua esortazione mostra chiaramente che il cristiano, e nello specifico il dottore della verità cattolica, non si pone a difesa di una delle tante posizioni ideologiche, non a difesa della propria persona e della propria dottrina, ma a difesa della dottrina che nella pienezza dei tempi è stata rivelata da Gesù: «Non io vi scongiuro ma la carità di Gesù Cristo. Prendete solo l’alimento cristiano e astenetevi dall’erba estranea che è l’eresia. Coloro che per farsi credere mescolano Gesù Cristo con se stessi, sono come quelli che offrono un veleno mortale nel vino melato».