Adriano Olivetti. Valori “made in Italy”
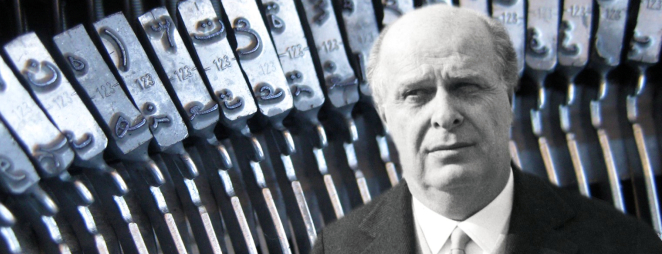
Sisifo, il più astuto tra i mortali, fu punito da Zeus con questo compito: portare un macigno sulla cima di una montagna; una volta arrivato in cima il masso rotolava di nuovo a valle, per cui Sisifo doveva ricominciare daccapo. Ogni giorno, e per l’eternità.
Lamentano la stessa sensazione, in Italia, molti di coloro che lavorano o vogliono lavorare. È come se dicessero: “Tanti anni di studio a spingere un ‘macigno’, anche fino alla laurea, e poi su e giù condannati a cercare un lavoro qualsiasi; tanta fatica per un lavoro stabile, e poi su e giù per arrivare alla pensione; tanto penare per una pensione, e poi su e giù a chiedersi cosa sia rimasto del nostro lavoro e di tanti sacrifici”.
Si va diffondendo un sentire collettivo nel quale convergono sfiducia profonda nell’agire umano, fatalistica accettazione del presente, radicato pessimismo generato dall’idea che ogni tentativo di cambiamento sia tragicamente impossibile. Nelle vie delle moderne metropoli, o nelle aule dei nostri Atenei, sembrano riecheggiare, paradossalmente, «I motti degli antichi» del mondo rurale di Verga: «Chista è la vita» (Così va il mondo), «Munnu è statu e munnu è» (il mondo come stato così continua a essere). Una visione, quella sull’attuale condizione lavorativa in Italia, più metafisica che storica; un’indignazione e un pessimismo più universali che contingenti. E si sa, proprio come accade ai personaggi di Verga, più avanza il fato più indietreggia la Provvidenza; se così è, non resta che arrendersi all’«ideale dell’ostrica»: soltanto quelli che si adattano alla propria condizione potranno salvarsi.
Non è per tutti così, e non deve essere così. Occorrerebbe far memoria – oggi più che mai – di uomini italiani capaci di autentico cambiamento, perché dotati di grande fiducia nell’agire umano e nell’azione della divina provvidenza nel tempo. Quanti italiani conoscono la vita di Steve Jobs, e quanti sanno, invece, che il nostro Adriano Olivetti inventò la prima macchina da scrivere portatile, uscita nel 1932 con il nome di MP1? Comunque, Olivetti non fu solo questo. Basterebbe visitare il sito della Fondazione Adriano Olivetti, per rendersi conto che fu uno dei più grandi innovatori del Novecento, non solo in campo industriale e imprenditoriale; si occupò di problemi di urbanistica, di architettura, di cultura, di riforme sociali e politiche che costituiscono la base programmatica del Movimento Comunità fondato nel 1947. Tra le tante attività, già prima della guerra, Olivetti fondò la casa editrice NEI (Nuove Edizioni Ivrea), trasformata, nel 1946, nelle più celebri Edizioni di Comunità.
Dal 2012 le Edizioni di Comunità sono tornate con un nuovo progetto editoriale che prevede la pubblicazione di cinque scritti di Olivetti, nella collana Humana Civilitas, per riflettere su alcuni temi della discussione politica e culturale attuale. Costruire una società a “misura d’uomo” «unita nella consapevolezza della centralità dei valori dello spirito e di quelli della cultura», e in cui le opportunità del progresso tecnologico sono indirizzate alla costruzione di «un mondo materialmente più realizzato e spiritualmente più elevato»: era questo il progetto – contemporaneamente politico, economico e culturale – di Adriano Olivetti. Un programma che traspare già dal primo scritto pubblicato da Edizioni di Comunità, dal titolo «Ai lavoratori», dedicato a due importanti discorsi che Olivetti fece agli anziani della sede di Ivrea (1954), alle cosiddette «Spille d’Oro», e agli operai di Pozzuoli, per l’apertura dello stabilimento (1955). (Adriano Olivetti, Ai Lavoratori, Edizioni Comunità, Roma/Ivrea, 2012, pp.53)
In entrambi i discorsi, Olivetti delinea con chiarezza quale modello di impresa ha in mente. Ricorda subito, nel discorso alle «Spille d’Oro», l’ammonimento del padre Camillo: «Tu puoi fare qualsiasi cosa tranne licenziare qualcuno per motivo dell’introduzione dei nuovi metodi, perché la disoccupazione involontaria è il male più terribile che affligge la classe operaia». Così fu. L’introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, adottati da Olivetti fin dagli anni Trenta, mai sarà causa di licenziamento; anzi, il giovane imprenditore espanderà stabilimenti e sedi di rappresentanza al Nord come al Sud, penetrando ben al di fuori dei confini nazionali, e assumendo in pochi anni 10.000 lavoratori in Italia e altrettanti all’estero. Senza apportare tagli all’occupazione, e rispettando le necessità produttive, Olivetti concepirà le fabbriche come «indimenticabile dimora di ogni giornata»: mirabili opere d’architettura, dotate di moderni servizi per tutti i dipendenti – come mense, asili nido, biblioteche, centri sportivi. Moltiplicherà, in pochi anni, la produzione di macchine per ufficio per dieci quindici volte: da una parte, potenziando l’organizzazione commerciale e la formazione dei venditori; dall’altra, unendo all’innovazione tecnologica dei prodotti un migliore design. Nel 1959, ben il 10 per cento dei dipendenti era impiegato nella ricerca. Tutti questi fattori, combinati, permettevano di realizzare utili rilevanti che diventavano, come s’è visto, «alti salari, magnifiche architetture, una buona qualità del lavoro, una crescente occupazione, nonché servizi sociali e culturali senza paragoni». Un modello d’impresa, quello di Olivetti, che, come emerge in più punti dei due discorsi, si proponeva anche come alternativa economico-politica: «creare un’impresa di tipo nuovo al di là del socialismo e del capitalismo».
Il successo di Olivetti non fu un caso ma il risultato di un’idea di management «audace nel piano, minuziosa nell’esecuzione, implacabile contro gli ostacoli», come egli stesso la definisce. E non solo d’innovazione tecnologica si parla. Filo conduttore di tutta l’esperienza di Olivetti, infatti, è credere che il lavoro sia un valore da tutelare, perché in esso si esprime la persona umana nella sua interezza e verità: «La Spilla d’oro sa che il lavoro che egli ha dato per anni alla fabbrica è qualcosa di intimamente e profondamente suo, onde a poco a poco questo suo lavoro è divenuto parte della sua anima. […] Il lavoro è perciò spirituale e il lavoratore si sente anch’egli nel lavoro e sul lavoro vicino a Dio, come Suo collaboratore e servitore». E l’azienda, in virtù del «principio di restituzione», deve tutelare il lavoro per il suo valore spirituale, e rispettare e promuovere la dignità del lavoratore «perché in fondo è grazie ad essi se ottiene notevoli risultati economici ed è in grado di ottenere profitti». Il modo adottato e suggerito da Olivetti, per risarcire questo debito, era associare a buoni salari anche buoni servizi sociali (mensa, asili nido, biblioteca, centri sportivi…ecc.). In nome del rispetto che nutriva per il lavoro e i lavoratori, come si legge in entrambi i discorsi, Olivetti affidava i lavoratori alla «Provvidenza perché protegga la loro coscienziosa e intelligente fatica».
A partire dagli anni Trenta, in un periodo difficile e in un settore fortemente concorrenziale, Olivetti fu un imprenditore di successo: quando successo significava mantenere e creare occupazione, aumentare il fatturato, realizzare nuovi stabilimenti, rinvestire gli utili in opere sociali e culturali a vantaggio dei lavoratori e della società tutta. Tutto questo, Olivetti lo fece mosso da grande fiducia nell’agire umano e della Provvidenza nel tempo. Oggi, invece, il concetto di successo d’impresa è capovolto: l’impresa deve creare utili per massimizzare i capitali degli azionisti, e per far lievitare i compensi di manager di media trecento volte superiori a quelli di un operaio. Per capitalizzare questi privilegi si possono anche chiudere gli stabilimenti e licenziare gli operai, ricorrere allo sfruttamento e al precariato, se così si abbattono i costi di produzione e gli oneri salariali. Rinvestire gli utili in servizi sociali e culturali, fuori e dentro l’azienda, è “fanta-impresa”. Un sistema eticamente ingiusto e, per di più, non produttivo. Tutti lo sappiamo, tutti lo pensiamo. Ma arrenderci al fato e all’«ideale dell’ostrica», «Munnu è statu e munnu è», non è inevitabile.
Per esempio, sarebbe segno di responsabilità e coscienza civica tornare a guardare all’esperienza di Olivetti bruscamente interrotta a causa della sua morte improvvisa nel 1960, a 59 anni. Non vuota novità per la novità, infatti, sarebbe pensare che un autentico cambiamento politico ed economico possa fondarsi e procedere solo con lo sviluppo dei valori spirituali e culturali: «Il mondo moderno deve accettare il primato dei valori spirituali se vuole che le gigantesche forze materiali alle quali esso sta rapidamente dando vita, non solo non lo travolgano, ma siano rese al servizio dell’uomo, del suo progresso, del suo operoso benessere». Una proposta per tutti, quella di Olivetti, per ricominciare ad avere fiducia nell’agire umano e non arrendersi al presente; una proposta per i cristiani, soprattutto, per tornare alla forza rivoluzionaria del cristianesimo delle origini: «Il mondo moderno rassomiglia stranamente al tempo in cui ebbero vita nelle Chiese primitive d’Oriente e di Roma gli albori del Cristianesimo. I primi cristiani con la loro opera, la loro giustizia, dileguarono a poco a poco l’etica materialistica del loro tempo, e animarono i popoli e i re di uno spirito nuovo. Oggi i testimoni della verità devono ancora servirsi delle forze sovrannaturali per vincere il disordine del mondo moderno solo decorativamente cristiano, e condurlo pienamente, con slancio nuovo, verso forme nuove».
Sisifo o Olivetti? Basta scegliere il “mito” vincente.

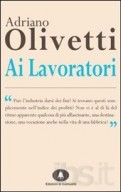



Le ragioni di una conversione sono sempre molto complesse, non mi pronuncerei. Sappiamo che i valori di riferimento di Olivetti furono spirituali, non confessionali ma profondamente cristiani. Ho trovato molti punti di contatto con la dottrina sociale della chiesa cattolica: la dignità del lavoro fondata sulla dignità della persona, e quest’ultima fondata sulla dipendenza creaturale da Dio. Un affascinate equilibrio tra principi cristiani, principi del migliore umanesimo, indubitabile competenza micro-macro economica. Grazie.
articolo molto bello, complimenti!
pero un banale osservazione: olivetti era ebreo-valdese, non aveva avuto una formazione dogmatica, si convertì al cattolicesimo solo……per una superiorità teologica.
forse quello che è stato gli deriva proprio d non essere organico al cattolicesimo….