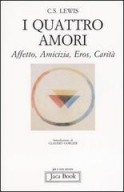Educazione sentimentale (II)

Concludiamo la nostra lettura guidata de I quattro amori (Clive Staples Lewis, I quattro amori, Jaca Book, 2011) [prima parte, clicca qui]. Prepariamoci a seguire C.S. Lewis nel suo viaggio dentro l’animo umano – tra affetto-amicizia-eros-carità –, schivando gli illusionismi di cui è capace il cuore, per arrivare – ci piace pensare – fino all’isola che c’è; un’“isola” dove l’amore non muore, non ci uccide, ma ci trasforma in modo mirabile.
Affetto (pp.37-57): Per il principio per cui «ciò che è in alto – dice l’Imitazione – non si regge senza ciò che sta in basso», Lewis inizia l’analisi da quello che dice essere il più umile e universale tra tutti gli affetti naturali e che i greci denominavano storge: «affetto, specialmente dei genitori verso la prole». L’affetto richiede un rapporto di parentela, o almeno di vicinanza: lega persone che, se il “caso” non avesse deciso di mettere a vivere nello stesso ambiente familiare, nella stessa scuola, o parrocchia, non avrebbero mai avuto niente in comune. Nell’amicizia e nell’eros scegliamo le persone di cui apprezziamo «qualità condite e servite come piace al nostro palato», e delle quali siamo orgogliosi di essere amici o innamorati; l’affetto, invece, ci allena «a notare, poi a sopportare, quindi a sorridere, a godere, infine ad apprezzare le persone che per caso ci troviamo accanto». Tutti gli affetti naturali, per quanto distinti e distinguibili, tendono a mescolarsi e sovrapporsi l’uno all’altro. L’affetto dona un fascino particolare e un vigore superiore all’eros e all’amicizia, facendoci godere la prosaica quotidianità e il semplice agio del nostro rapporto:«non si avverte la necessità di parlare né di scambiarsi tenerezze: sembra che non ci sia bisogno di nulla se, non forse, di attizzare il fuoco».
Se queste sono le caratteristiche principali dell’affetto, ci sembra che la peculiarità dell’analisi di Lewis stia nel ritenere che le suddette siano tutte ambivalenti: possono essere messe a buon frutto, come pure a cattivo frutto.
Questa ambivalenza dell’affetto, nel libro, è personificata dalla “Signora Fidget”: «“Quella donna vive per la sua famiglia – dicevano – che moglie, e che madre!”. Faceva tutti i bucati da sola. Vero; lo faceva male, e si sarebbero potuti permettere la spesa della lavanderia; spesso la pregavano di non farlo, ma lei continuava ostinatamente. C’era sempre qualcosa di caldo a pranzo per chi restava a casa, e sempre qualcosa di caldo per cena (anche d’estate). La imploravano di non preparare nulla; le giuravano, quasi con il pianto in gola, di preferire i piatti freddi (ed era vero), ma senza risultato. […]. La signora Fidget, infatti, com’era solita ripetere si “ammazzava di lavoro” per la sua famiglia. Non c’era modo di impedirglielo, né era possibile restarsene seduti a guardarla, senza sentirsi in colpa. Dovevano aiutarla; la verità è che si sentivano sempre in dovere di aiutarla. Il che significa che erano costretti a fare delle cose per lei, onde aiutarla a fare delle cose per loro che, personalmente, non desideravano ella facesse».
Da questo ritratto, risulta evidente come l’ambivalenza dell’affetto si giochi tutta sul precario equilibrio tra «amore bisogno» e «amore dono». Anche l’affetto per eccellenza, l’affetto materno, è sempre un «amore dono», sì, ma tale da avere anche bisogno di donare. Questo è inscritto nella natura: la donna, è vero, partorisce per dare la vita, tuttavia – se non partorisse – morirebbe sicuramente. Questo bisogno di rendersi necessari può diventare famelico e fagocitare il proprio oggetto di affetto, «tenendolo in una condizione di eterna dipendenza o creando in lui bisogni fittizi».
Il carattere naturale e immeritato dell’affetto, poi, può sviluppare la malsana convinzione che abbiamo sempre il dovere di darlo, o diritto di aspettarcelo. La continua richiesta di affetto da parte di quelle persone che lo reputano un loro diritto, e il bisogno di conferme e gratificazione da parte di quelli che lo considerano un dovere, generano sensi di colpa ingiusti e frustranti in chi è vittima di queste pretese. Tra tutti i sentimenti naturali, poi, l’affetto è il più geloso: ogni cambiamento rappresenta una minaccia per l’affetto. Una madre e un padre crescono un figlio condividendo, fino ad una certa età, tutto; non appena il figlio cominci ad avere interessi, affetti, e progetti tutti suoi, i genitori possono sviluppare un ingiustificato senso di esclusione, giudicando in maniera distorta e pregiudiziale “chi” o “cosa” porti via nostro figlio, il «disertore».
Secondo Lewis, questi esiti nefasti dell’affetto, non sono da considerare patologie della dimensione affettiva, devianze di pochi nevrotici. Chi può dire, onestamente, di non essere stato mai una «Signora Fidget» nel modo di esternare l’affetto? Chi può dire di essere capace, naturalmente e per istinto, di un affetto esclusivamente «amore dono», capace di operare «in vista della propria abdicazione»; «“Non ha più bisogno di me” dovrebbe essere il momento della nostra ricompensa».
L’affetto, lasciato da solo, non riesce a fare questo. L’affetto, se si nutre solo di sé, finisce per rivoltare verso stesso la propria fame di «amore bisogno» e «amore bisogno di dare», divorandosi. L’affetto, conclude Lewis, si salva solo se ci aggiungiamo qualcosa di diverso da se stesso. Che cosa?
Amicizia e Eros (pp. 59-106): L’amicizia è il meno naturale dei nostri affetti: sia l’individuo che la comunità sopravvivono anche in sua assenza. La frase con cui comincia un’amicizia –scrive Lewis– è qualcosa di questo genere: «Come? Anche tu? Credevo di essere l’unico…». L’amicizia deve avere un oggetto: «chi non possiede nulla, non può condividere nulla; chi non sta andando da nessuna parte non può avere compagni di viaggio». Gli amici condividono la «stessa visione»: hanno una domanda in comune – «hai a cuore la stessa verità?» – anche se le risposte possono essere diverse. La verità condivisa è il tramite che permette lo sviluppo di reciproca conoscenza e affetto, ma, a differenza dell’affetto, l’amicizia non è condizionata dal bisogno di sentirsi necessaria: «il marchio della perfetta amicizia non è il fatto di essere pronti a prestare aiuto nel momento del bisogno (anche se questo si verificherà puntualmente), ma il fatto che, una volta dato questo aiuto, nulla cambia». Tra tutti gli affetti, poi, l’amicizia è il meno geloso; a patto che si abbia a cuore la stessa verità, il nostro godimento degli amici aumenta, e non diminuisce, con il numero di quelli con cui condividiamo.
L’eros – per Lewis – è quel tipo di amore proprio degli innamorati; la sessualità, svincolata dal sentimento, è denotata dall’Autore come «venere». Questa distinzione è solo funzionale al discorso, non ha nessun intento morale. Anzi, Lewis ricorda come la maggior parte dei nostri antenati furono costretti a sposarsi e a procreare in base a criteri che non avevano nulla a che fare con l’eros, e furono mogli, mariti, genitori esemplari; mentre una «venere» associata ad un «eros trascendente e cangiante» può condurre un marito a tradire, o una madre ad abbandonare i propri figli: «Dio non ha voluto che la differenza tra un peccato e un dovere fosse affidata ai buoni sentimenti».
Se gli amici stanno fianco a fianco assorti in qualche interesse in comune; gli innamorati stanno quasi tutto il tempo faccia a faccia assorti nella contemplazione. L’eros è «amore dono» e amore bisogno», come tutti gli affetti, ma è specificatamente «amore apprezzamento»: fa desiderare ad un uomo non una donna, ma una donna in particolare; per quello che quella donna è, e non per il piacere che gli può procurare. L’eros è indifferente a tutti i calcoli; una volta in noi – lo sa chi ha provato a dividere due innamorati – ci fa preferire l’infelicità con l’amata alla felicità in qualsiasi altra condizione: «Anche quando diventa chiaro, al di là di ogni possibile illusione, che il matrimonio con l’amata non potrà in nessun caso renderci felici – quando l’unica prospettiva che si apre davanti a noi è l’accudire un’invalida permanente, una povertà senza speranza, l’esilio o il disonore – l’eros non esita a dire:“Sempre meglio che separarci; meglio essere infelici con lei, che felici senza di lei. Che i nostri cuori si spezzino pure, a patto che si spezzino insieme”. Se la voce dell’eros, dentro di noi, non parla in questi termini, allora non è la voce dell’eros». Questa è la grandezza dell’amore, e il terrore per chi non l’abbia provato; ma chi lo conosce – scrive Lewis – sa che nell’eros, accanto alla grandezza, vi è sempre la giocosità: «Persino quando le circostanze in cui gli innamorati vengono a trovarsi sono cosi tragiche che nessuno, che vi sia testimone, riesce a trattenere le lacrime, loro invece – nel bisogno, nella corsia di un ospedale, in prigione nei giorni in cui sono permesse le visite – saranno assaliti da un’improvvisa allegria».
Tutti gli affetti sono, in realtà, sempre mescolati insieme, o possono trasformarsi l’uno nell’altro: tra due persone legate da un vincolo di profonda amicizia, a meno che essi non si trovino fisicamente sgradevoli, è quasi certo che prima o poi la loro amicizia si trasformerà in attrazione sessuale; ugualmente, un amore sensuale può portare ad una amicizia tra i due innamorati, e, visto che l’amicizia ha una forza pari a quella dell’eros, non è detto che messi davanti all’alternativa sia facile scegliere, tra la prospettiva di rimanere sempre uniti nella ricerca della stessa verità o gli ardori e le meraviglie dell’eros.
Una volta delineate le caratteristiche dell’amicizia e dell’eros, Lewis, come aveva fatto per l’affetto, passa a dimostrare come le suddette siano costitutivamente ambivalenti, e, di conseguenza, possano portare sempre tanto buon frutto quanto cattivo frutto.
Per prima cosa, l’amicizia può essere scuola di virtù o di vizi. Se la caratteristica fondamentale che contraddistingue gli amici è «avere a cuore la stessa verità», da questa esperienza comune potranno nascere opere d’arte, filosofia, progressi nel campo della religione o della morale; «ma chi può escludere che da essi nascano la tortura, il cannibalismo, o i sacrifici umani?». Nell’amicizia, poi, lo stesso cameratismo – che unisce persone che si apprezzano e condividono lo stesso orizzonte, o almeno guardano allo stesso orizzonte – può diventare un male, se si trasforma in orgoglio corporativo, se porta a considerarsi un “noi” rispetto ad un “loro”, ad escludere piuttosto che a distinguere. Un gruppo di amici corre il rischio di arrivare a considerarsi un’élite, tanto più elevati sono i propri interessi. Arrivati a questo punto, la superbia non si arresta, e il gruppo può esaurirsi in una coterie, una piccola cerchia di aristocratici che si sono auto-investiti di questo titolo, e non condividono altro che la volontà di sopravvivere a se stessi e alla propria superbia.
Per quanto riguarda l’eros, nella sua stessa grandezza si annida un seme dannoso. L’eros – che ci fa dire «preferisco vivere infelice con mia moglie che felice da solo» – ha qualità divine, che testimoniano la nostra «vicinanza a Dio per somiglianza» ma non portano necessariamente ad una «vicinanza a Dio per accostamento». L’eros, proprio quando è al suo massimo d’intensità e rassomiglia di più al modo di amare di Dio, diventa più incline ad assolutizzarsi e ad esigere da noi adorazione: «la sua totale disponibilità, il suo incurante spregio della felicità, il suo passare sopra a qualsiasi considerazione personale, può spingerci fino a trasformare l’eros in una religione»; gli innamorati, compiacendosi dei propri sacrifici, arrivano a considerarsi dei martiri, ad «identificare l’eros con la voce stessa di Dio» fino a fare voti senza che nessuno glieli chieda». Chi arriva a pensare che l’eros abbia il potere e l’autorità di un dio, e la capacità di realizzare la nostra completa felicità, quando resterà deluso una volta, due, molte, si accorgerà che l’eros da solo non riesce a mantenere le sue promesse, perché «dopo averci fatto intravedere di cosa sia capace, ha esaurito il suo compito».
Anche l’eros e l’amicizia, come l’affetto, lasciati a se stessi, finiscono per auto-annientarsi, per rivoltare verso stessi la propria fame di «amore bisogno» e «amore bisogno di dare», auto-divorandosi. Anche l’eros e l’amicizia, conclude Lewis, si salvano solo se ci aggiungiamo qualcosa di diverso. Che cosa?
Carità (pp-107-127): Tutti gli affetti naturali sono segnati da un’ambivalenza costitutiva, strutturale: nessuno è solamente buono, o solamente cattivo, se lasciato in balìa di se stesso; gli affetti non riescono a restare sempre uguali a se stessi né a realizzare tutto quello che promettono. Dire questo non significa sminuire gli affetti naturali, ma indicare quello che sono e quello che non possono essere: questa è l’unica terapia perchè non uccidano noi, né muoiano essi.
L’amore è molto, moltissimo, ma “tutto per amore” è la sua vera condanna a morte: se le cose umane trapassano, allora non possiamo far dipendere la nostra felicità da qualcosa che potremmo perdere, potrebbe mutare, perfino ingannarci. Non dobbiamo, per questo, diventare cinici, né amare “di meno” gli altri per prudenza, o per difenderci. Dobbiamo diventare realisti; non cedere alla tentazione di trasformare gli affetti in degli idoli, perché solo gli idoli promettono quello che non possono dare, quello che può dare solo Dio. Scrive Lewis: «Quando arriva Dio i semidei possono restare. Lasciati in balìa di se stessi, essi finiscono per svanire, o diventano dei demoni. Solo nel suo nome essi possono, con bella sicurezza, maneggiare i loro “piccoli scettri”».
Il peccato degli affetti naturali – che può nascondersi anche dietro l’affetto più oblativo, casto e spirituale – è quello di essere gelosi di Dio, di volersi sostituire a Lui, rivaleggiando con l’amore che noi dobbiamo a Dio. «Se uno viene a me e non ama meno di me il padre e la madre, e la moglie…ed anche la sua vita, non può essere mio discepolo» (Lc 14, 269); queste parole ci dicono che bisogna rifiutare, affrontare, non fare concessioni alle persone amate se esse si interpongono tra noi e la nostra obbedienza a Dio. Anzi, prima ancora di arrivare a questo punto, bisognerebbe «far capire a una moglie, ad un marito, a una madre, o ad un amico, che il nostro amore per lui era fin dall’inizio soggetto ad una limitazione – “sottomesso a Dio” e “fin dove lo consente un amore più alto”».
Quando Dio sta al suo posto, gli idoli non possono più ingannarci nutrendoci di promesse che non sanno mantenere; tutti gli affetti naturali non solo non vengono mortificati, ma vengono esaltati e resi più potenti. Da Dio, infatti, arriva quel qualcosa in più che solo salva l’affetto, l’amicizia e l’eros dal loro auto-divorarsi: la carità. Dio, attraverso la carità, trasfigura tutti i nostri affetti, donandoci un divino «amore dono» e un divino «amore bisogno».
L’«amore dono» naturale, anche quello materno, è sempre diretto verso oggetti che l’innamorato considera intrinsecamente amabili, con cui condivide un punto di vista comune, o verso coloro che sappiamo capaci di riconoscenza, che lo meritano, o che esercitano su di noi un certo fascino perché indifesi. Il divino «amore dono», invece, è «quello che ci permette di amare ciò che per sua natura non è amabile: i lebbrosi, i criminali, gli imbecilli, chi si atteggia uomo superiore, chi si fa beffe del prossimo». Dio permette perfino un «amore dono» divino dell’uomo verso se stesso, quello che spesso lo salva, facendogli avere misericordia delle proprie peggiori inclinazioni. Dio trasforma anche il nostro «amore bisogno» naturale: noi desideriamo essere amati per la nostra intelligenza, bellezza, generosità, utilità; quando ci accorgiamo che qualcuno ci sta offendo la carità – il più alto degli affetti, siamo presi da stizza, perche è un affetto che non ci conferma nel nostro valore, non ci gratifica, e in un certo senso ci umilia perché ci fa dipendere da altri. L’«amore bisogno» divino, invece, è quello che accetta lieto, senza vergogna, la carità: è il sorriso riconoscente e per niente mortificato del marito malato, che si ritrova inutile, odioso, disgustoso, dipendente da tutti, ma sa sorride alla moglie che lo assiste e lo cura, senza sentirsi umiliato o stizzito.
Dio, attraverso la carità, trasfigura tutti i nostri affetti umani, li esalta, li salva dall’auto-divorarsi, ma fa ancora di più: Dio trasforma i nostri stessi affetti naturali in uno strumento di carità, pur restando quello che sono, cioè affetti naturali. Scrive Lewis: «Come Cristo è vero Dio e vero Uomo, così gli affetti naturali sono chiamati a diventare perfetta carità e anche perfetti affetti naturali. “Non convertendo la divinità nella carne, ma assumendo su di Sé l’umanità”, così la carità non scade a semplice affetto naturale, ma è affetto naturale che viene elevato a strumento obbediente e accordato da colui che è l’amore stesso».
Eccoci approdati, alla fine di questo lungo viaggio, nell’“isola” dove l’amore non uccide e gli affetti non muoiono. Godiamo il riposo del cuore che sa vivere nella pienezza l’affetto, l’amicizia e l’eros, lasciandoli trasfigurare, non snaturare, dalla carità. L’“isola” dove «un gioco, uno scherzo, una bevuta in compagnia, chiacchiere futili, i piaceri di “venere”, tutto può diventare un mezzo attraverso cui dare, o accettare perdono, con il quale consolare o venire riappacificati, oppure dimenticare il nostro profitto personale. In questo modo proprio nei nostri istinti, nei nostri appetiti e svaghi l’amore prepara per sé un “corpo”».