Alla ricerca dell’unità [smarrita]

È dura affermare che gli Italiani hanno saputo – una volta di più – mostrarsi conformisti, in quanto concerne questi tanto discussi festeggiamenti: “festa o non festa?” “festa nazionale o non festa nazionale?”, “giorno di lavoro o giorno festivo?”. E ancora: “bandiere o non bandiere?”, “sì, ma quali bandiere poi?”, “come ‘quali bandiere?’?”, “eppoi perché proprio il 17 marzo?”, “ma perché, che è successo il 17 marzo?”, “boh, forse c’entra con la guerra”, “ma quale guerra, centocinquant’anni fa!”, “ah, e allora che è successo?”…
Così, con un’incomprensibile metamorfosi, il camaleontismo della sinistra italiana è riuscito a patrocinare – almeno nell’opinione pubblica – questi festeggiamenti e a farne (indovina un po’?) un’altra testa d’ariete contro la fortezza berlusconiana. Al grido di guerra: «La Costituzione non si tocca!» l’Armata Brancaleone capitanata (si fa per dire) da Bersani si riversa nelle strade gridando “al lupo! al lupo!”, e sarebbe interessante chiedere a quelle migliaia di girotondini una valutazione personale sul contributo del cosiddetto Codice di Camaldoli ai lavori della Costituente (di un anno posteriore). Giusto per esemplificare come certo politicume italiota si costituisca a capo di fazioni (purtroppo) inesistenti e si lancî al galoppo verso campi di battaglia ormai deserti – privi anche dei fantomatici mulini a vento di Cervantes.
Sì, perché in questa farsa uno viene a “scoprire” che «la Costituzione l’hanno fatta i comunisti»! Solo favole berlusconiane? E allora perché quegli altri la patrocinano come se fosse un patrimonio peculiarmente “loro”? Ma poi, ancora una volta, chi sono “loro”? Questo miscuglio indeterminato di partitini e personaggini, che spende una fortuna incalcolabile per coprire l’Italia di manifesti a ogni tre per due, chi rappresenterebbe?
Alla fine uno scopre, tramite Google e Wikipedia, che il 17 marzo 1861 è avvenuta, a Torino, l’incoronazione di Vittorio Emanuele II, con la quale veniva fondato il Regno d’Italia: «Oddio, e che è ‘sta cosa? Ecché, siamo tornati alla Monarchia? A noi ci piace la Repubblica, ci piace – no’ come a quello là, che va pure colle minorenni», e di nuovo torna giù tutto, nel calderone di un’italietta (no, questa parola non si può scrivere con la maiuscola!) che dice di gioire di un giardino ideologico variegato ma che poi non resiste alla tentazione di approcciare e comprendere ogni cosa in sistema binario.
«Una gente che libera tutta,
O fia serva tra l’Alpe ed il mare;
Una d’arme, di lingua, d’altare,
Di memorie, di sangue e di cor»
(Alessandro Manzoni, Marzo 1821)
Era un altro marzo, anteriore a questo e anteriore anche a quello di Vittorio Emanuele II: la penna di un fervente patriota esortava e sospirava l’azione unificatrice di un avo del futuro Re d’Italia. Nei versi di Manzoni si riannodano mirabilmente, oltre ai contenuti del concetto di “popolo” (su cui torniamo tra poco), anche le istantanee dei diversi atteggiamenti avuti dai cattolici italiani nei confronti dei movimenti indipendentisti, nonché finalmente l’ambiguo e mai composto rapporto tra gli Italiani e il “loro” “Risorgimento”. Procedendo a ritroso, cosa si può dire quando capita di vedere che nei programmi televisivi che ultimamente stanno dedicando all’anniversario nazionale vengono proiettate tra le immagini dei fautori del Risorgimento anche fotografie di Antonio Gramsci? C’è stata un’Italia (ed era di cultura, va detto, prevalentemente marxista) in cui ogni liceale conosceva il succo della radicale critica gramsciana al Risorgimento italiano. Evidente che abbiamo a che fare con altra gente, quando vediamo platee di spettatori che applaudono felici il volto di Gramsci (ormai presumibilmente anonimo ma simpatico quanto quelli del Che, di Giordano Bruno e di Gesù).
L’andamento poi del sentimento patriottico tra i cattolici di lingua italiana (definiamoli così, in generale) è sinusoidale fin dal cuore del Risorgimento: dal liberalismo entusiasta di cui lo stesso Manzoni è grande icona fino al sogno giobertiano (cui lo stesso Pio IX volle per qualche tempo credere) e poi di colpo indietro – dal Non expedit del 1868 e per Porta Pia scrosciava la doccia fredda sui non consumati amori tra il Regno d’Italia e la Sede Apostolica. E poi? Nel silenzio “ufficiale”, una cova reazionaria da cui spuntò per un verso la speranzosa adesione alla Conciliazione mussoliniana (cui parve credere per un po’ anche Pio XI), e per l’altro – già prima del ’29 dei Patti Lateranensi – l’audace e profetica scintilla di Sturzo e del Partito Popolare: «Il ritorno dei cattolici in politica colse impreparati sia i liberali sia i comunisti, i quali pensavano che durante la guerra il pensiero cattolico si fosse rinchiuso esclusivamente nella gestione del culto» (cf. Francesco Occhetta su La Civiltà Cattolica 3832, 20 febbraio 2010).
Ecco i postumi mai smaltiti dell’anomalia del Risorgimento italiano: esso ha «coniugato l’indipendenza nazionale e le istituzioni rappresentative come espressione delle libertà individuali» (con le parole di Ernesto Galli della Loggia in un’intervista rilasciata il 24 febbraio u.s.). Certo, il fascismo aveva cancellato, de facto, l’espressione di queste “libertà individuali”, ma la condizione del suo potere riposava anche sul “matrimonio” con la casa reale che di quel Risorgimento studiato a tavolino (e finanziato in parte da moneta massonica estera) era la concretazione istituzionale. Che confusione! Fortuna che almeno la pizza Margherita resta in tutto il mondo come simbolo d’italianità nobile e sobria, semplice e generosa: come stava effettivamente scritto nel suo nome, la Regina Margherita fu la perla dei decennî a cavallo tra i due secoli. In lei è dato scorgere uno dei più potenti catalizzatori di consenso pubblico dell’epoca (Montanelli la definì “una professionista del trono”), capace perfino di accordare in sé le dissonanti tensioni dell’epoca: conquistò la neonata Italia solo mostrandosi alle folle in un viaggio col marito, ma questi si espose così a più di un attentato (l’ultimo dei quali fatale) laddove lei restò per sempre nei cuori di popoli che avevano buon diritto di vederla come una conquistatrice. Anche Giosuè Carducci ne restò stregato, e le dedicò una delle Odi barbare, che nelle ultime due stanze suona così:
«fulgida e bionda ne l’adamàntina
luce del serto tu passi, e il popolo
superbo di te si compiace
qual di figlia che vada a l’altare;
con un sorriso misto di lacrime
la verginetta ti guarda, e trepida
le braccia porgendo ti dice
come a suora maggior “Margherita!„»
(Giosuè Carducci, Alla Regina d’Italia)
Il convoglio ferroviario che ne trasportò la salma da Bordighera a Roma, nel gennaio del ’26, somigliò a un corteo funebre lungo mezza Italia, costretto al passo d’uomo dalla folla che l’attendeva ai binarî per salutarla. Certo, il grosso di Casa Savoia (di ieri e di oggi), di fronte alla sua perla, è quasi la prova che la nobiltà non è questione di sangue.
Ma torniamo, infine, al popolo, alla sua crisi occidentale (dovuta anche a certo ingenuo europeismo): com’è che non sono più degli stranieri a frantumare lo scongiuro manzoniano – «Non fia loco ove sorgan barriere / Tra l’Italia e l’Italia, mai più!» – ma sono precisamente degli “italiani”, per di più legittimamente rappresentati nel Parlamento della Repubblica? Inutile (forse) spendere perorazioni da piagnoni sul decadimento dei sei pilastri manzoniani del concetto di popolo: biblioteche sono state scritte su questo trapasso epocale. Il “sangue” è stato il primo a cadere, e sappiamo a quale salato prezzo. L’“arme” cade da pochi anni, e così il popolo smette pure di essere identificato dal poter essere chiamato a morire. L’“altare” è frantumato da tempo, e il bonum pacis è per questo verso appeso all’invisibile filo della tolleranza. Proprio il “cor” è in dubbio, forse perché si sono perse le “memorie” e la “lingua”. Forse è perché solo la pizza Margherita può farci sentire Italiani senza dividerci in monarchici, repubblicani e repubblichini – sì, forse è per questo – che non riusciamo a festeggiare l’unità senza ripartirci in mille partigianerie (che poi sono sempre le solite due).
E se ripartissimo proprio dalla “lingua”, riscoprendone con amore il vigore, la storia, le traversie? Con voce quanto mai ambivalente, in questo contesto, i celebri versi di Buttitta ci ammoniscono dalla Sicilia del 1970:
«Un populu
diventa poviru e servu
quannu ci arrubbanu a lingua
addutata di patri:
è persu pi sempri».
(Ignazio Buttitta, Un populu)
Foto: omaggio alla Regina Margherita.


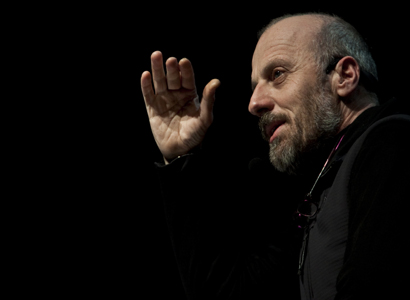

A dire il vero, certamente l’Italia troppo spesso si divide in modo inutile.Credo però che utilizzare certi simboli non sia di per sè ipocrita e che, se questa festa può essere l’occasione per risvegliare un sano sentimento nazionale, sia assolutamente necessario festeggiarla. Certo non bisogna cadere negli stereotipi o nell’ipocrisia di chi espone le bandiere ritendndosi migliore di un altroi o usandole per fini strumentali. Nè si potrebbe tollarera l’idea di un rafforzamento della xenofobia motivata dal “noi italiani, loro stranieri”. Però che ci sia un giorno, oltre a quelli che già celebriamo, tipo Festa della Repubblica del 2 giugno, in cui celebrare il nostro Paese, può aiutarci a riscoprire le nostre radici ed il senso del nostro stare insieme. Al di là della pizza Marcgherita. E a dire semplicemente (e non solo per tifare la squadra di calcio): viva l’Italia!